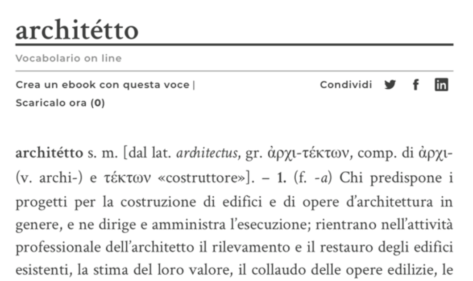Allora sarà passato questo tempo di elezioni, di giorni scuri di pioggia, di ansie prepasquali. I mandorli saranno ormai sfioriti e il calore spingerà i più a ripararsi sotto gli ombrelloni in qualche spiaggia d’occasione, il bel paese brillerà per luce estiva, le sagre paesane daranno fondo alla civiltà acquisita, le pance si scioglieranno al solleone, le tempeste rapide si dissolveranno nello spazio di poche ore…
I fulmini agitano le mie certezze, squarciano il cielo d’acciaio che si chiude stretto sui miei giorni.
D’estate il tempo corre via molto più in fretta.
Abbandona il ritmo inquieto e battente del melanconico autunno, lascia i tormenti e gli inganni dell’inverno, fa esplodere il senso di primavere ogni volta uguali, ogni volta diverse. Il tempo è la mia piccola illusione scandita dai sogni. Quand’ero bambino e la pioggia scendeva giù per le montagne del mio Appennino andavo spesso in cerca di acqua da raccogliere addosso sotto gli alberi di parchi oscuri e scabrosi. E le mie giornate erano castelli da scoprire, invenzioni da costruire, emozioni da schermare e proteggere. Poi il tempo è cambiato.
Piove ancora ma non è più come un tempo. E domani, chissà, una volta passate le elezioni, i giorni scuri di questa pioggia cittadina acida e invisibile, le ansie prepasquali che accompagnano questo degenerato figlio di una chiesa immota, il senso d’umidità sarà ancora diverso, ancora più violato e violento.
Il pugno sul viso.
Eppure sento che l’estate che verrà sarà ancora estate, tempo per individui intenti a battere strade troppo battute, tempo per altre domande senza risposta, tempo di canzoni allegre, di discoteche negate e sopravvissute, di miti sciolti al sole, di incertezze.
Sono figlio del mio tempo e non so rinnegarmi. Un pugno. Lo stomaco preme.
Mi piace parlare del tempo che fa fuori. Del tempo interno non possiamo far nulla. Ci guarda. Ci giudica con gli occhi buoni di un sole in mezzo al cielo azzurro e freddo.
Quando non so cosa dire faccio spesso ricorso al tempo. Chiedo soccorso alle stagioni, imploro parole che possano venire fuori da primavere malaugurate, inverni precoci, autunni al sole, estati d’afa invadente. E il tempo delle stagioni non mi delude mai, mi offre parole per rinnegare, compiacere, affabulare, sempre nuove, sempre vere. Eppure il mio tempo è coperto di infamie assurde per il solo bisogno che ho d’illudermi che ogni volta la mia stagione non è quella giusta. E non c’è mai giorno in cui possa dire del tutto convinto eccomi, sono qui, mi piace il tempo che fa fuori, sto bene, amo respirare a pieni polmoni, l’aria è fresca quel tanto che basta, ho i vestiti giusti per l’occasione, c’è un freddo pungente che anima la vita sonnolenta, che quel caldo che offre al sudore il sapore di una cosa pura. Eh, no. Fa sempre troppo caldo o troppo freddo. E allora giù a dire che freddo che fa, che caldo che fa, ci vorrebbe una leggera brezza, piove da troppo tempo, abbiamo avuto una stagione troppo arida e secca.
Ho visto mia madre più volte nei suoi anni migliori perdersi ad invocare un tempo per ogni stagione, figlia di terra contadina e cresciuta alla scuola di rivoluzioni mancate. Ancora oggi campa la sua storia antica pensando a raccolti da compiere e accetta il tempo delle stagioni come viene. Ma ne chiede sempre uno diverso. C’è il tempo del grano da raccogliere, della vendemmia, della barbabietola e del girasole. E ogni volta il suo viso racconta danze improbabili per propizie dovute. E intanto, danza dopo danza, raccolto dopo raccolto, la sua storia passa al vaglio delle stagioni mai troppo buone, mai uguali, mai primavera quando c’è primavera, mai autunno quando c’è autunno. alla fine mi sono chiesto attraverso i suoi occhi quali fossero gli autunni veri e quali le primavere.
Un pugno, sui denti.
Quanti pugni mi è capitato di incassare… tanti. Destino comune. E la faccia si gonfia, il dolore riempie di un’ansia incessante il trascorrere del tempo. Ma in fondo è una gioia, iniezione di vitalità e di calore nel freddo pungente che fa fuori. Ogni abbandono ha il sapore di un pugno. Quanti abbandoni, quante facce note, come maschere, nel magazzino dei ricordi e del tempo. Ogni volta che vivo un abbandono ritornano quelle stesse emozioni, quelle stesse paure, quello stesso vuoto. E allora rincorro l’infanzia, tutte quelle cose “piccoline” che immagino avessero un sapore meno amaro. Era davvero così?
Ho rincorso i sogni da allora, da quando immaginavo futuri poteri d’adulto immerso fra le carte ancora possibili dei miei giorni. Oggi incontro la maledizione dorata di un rifugio che inganna, che spaccia per gloria un’alienazione profonda e un disagio battente come un pugno, in pieno viso. Tutto ciò che ho voluto, per cui ho lottato mi sembra carico di inganni, trappola immortale in cui crogiolarsi inseguendo disperatamente il senso e la ragione.
Guardo la tv. Ingoio la tv. Ci sprofondo dentro, come in una nuvola, nel tentativo disperato di fermare il pensiero, di bloccare la vita di quell’angolo interno che – pugni, abbandoni, storie – cattura e strapazza a suo piacere. Ingoio prezzi giusti e novelle irreali, giornalisti e zuccherose ragazze in minigonna. E la mia storia continua, dura, come tante. Ma lì il pensiero si blocca. Al suono della tv si può vivere davvero lontani da sé stessi e questo, ora, mi fa bene. Mi dà li tempo di cui ho bisogno per leccarmi le ferite. Con cura.
Nell’abbandono sta la mia paura più grande. L’abbandono della vita, delle persone, delle cose che scappano via. Durante la mia adolescenza ho praticato con estremo furore la teoria del mordi e fuggi. Passavo da una storia all’altra, incantato, sospeso, convinto che la virtù del mondo risiedesse nella scoperta continua e senza limiti, nella moltiplicazione di eventi, letti, fragori e lacrime. E non capivo che stavo consumando il mio declino futuro. Oggi fra tanti volti noti che vengono e vanno nella mia mente, lasciati col dolore di un pugno pieno sul viso, ne ricordo uno, per tutti. Il volto di un amore un po’ chiuso straordinariamente bello e inquieto che rivedo seduto sui cuscini di una strana festa tedesca. Ne ricordo intatta l’abbronzatura estiva e un camicione azzurro leggero a coprire un costume capace di rilasciare l’odore di un pelle vinta dal sole. E la memoria va ad un viaggio in treno, alla domanda inquieta su un pensiero ossessivo, toccare l’amore, baciarlo, infrangere la distanza di due corpi intimamente soli. E ricordo il sapore di quel freddo, di notte, in un letto umbro d’altri tempi su cui forse mio nonno e mia nonna avevano unito i loro sessi contadini; e le mani desiderose di scoprire, di cercare nel buio immenso li calore di un’utilità. E’ sparito, un po’ dopo, l’amore, prima che ci fosse il tempo di dichiararselo, prima che ci fosse il respiro giusto per contenerlo. Dove sei, ora. Quanti pugni hai preso. Hai ancora quegli occhi possibili o ti stai spegnendo nella furia di tram, locali, strade e periferie.
Ho tirato talmente tanti sassi alla mia adolescenza che non so come fare a dirmi salvo. Salvi sono quelli che riescono sempre a trovare gli equilibri. Io mai. Ci provo, mi sforzo, mi scontro. Eppure alla fine rimango a terra e inizio il conto di quei dieci eterni secondi che mi riparano dal ko. Ho sempre la forza di alzarmi prima. Nessun pugno mi ha ancora annientato. Neanche il mio astuto, terribile controllo del mondo, passato al setaccio come si fa per dissodare quella terra, fine, che si ribalta ogni giorno d’autunno per darle un nuovo respiro, sempre più chimico, sempre più consumato. Un controllo che è un pugno, ogni volta, nello stomaco. In quello stomaco dove risiedono forti gli odori della vita, del cibo, del sesso, dell’amore. L’importante è non credere mai di bastare, a sé stesso, agli altri. E quando se ne ha l’illusione bisognerebbe entrare subito in conflitto, alzare le difese, ripassare le mosse che proteggono il viso e lo stomaco. Eppure non c’è nulla da fare. Si cade, lo stesso.
Pubblicato in «Società di pensieri», n. 9, giugno-settembre 1994